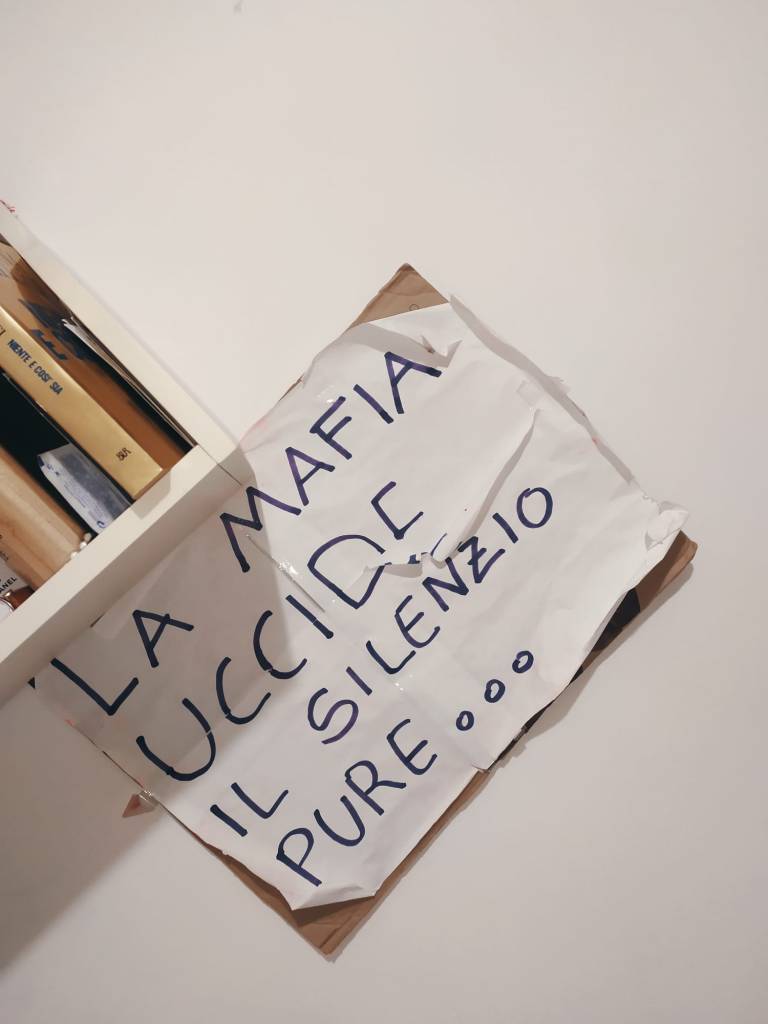Il cabaret dei sindaci e governatori, dalle Alpi allo Stretto
di Grazia Enerina Pisano

In piena emergenza Coronavirus, il cabaret è stato inaugurato da Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania che, con il suo slogan sui carabinieri con i lanciafiamme, dopo aver fatto breccia nel cuore degli italiani, ha conquistato perfino Naomi Campbell e le pagine del New York Times.
Il guanto della sfida non poteva non essere raccolto dai sindaci dell’intera penisola e così, in sole due settimane, il sindaco di Messina Cateno De Luca è riuscito a raggiungere gli studi Mediaset di Barbara D’Urso. Per lui, la strada del successo nazionale è stata inaugurata dal video comunale in cui gridava: “U babbiu vi accuì, intelligentoni deficienti; ve lo dico chiaramente, sappiate che domani vi becco, vi becco uno a uno” (voce del verbo babbiare, fare gli stupidi). Poi l’occasione di slancio, grazie alla caccia alla Renault 4 degli artisti di strada francesi diretti da Napoli ad Acitrezza (CT): i ragazzi senza fissa dimora, dopo quattro mesi in territorio italiano, durante la visita a Napoli, sono stati colti dall’emergenza Covid-19 e dalle nuove misure restrittive. Senza nessun’altra soluzione se non recarsi dagli unici contatti in grado di ospitarli per adempiere agli obblighi previsti dagli ultimi decreti, all’interno di una macchinina sgangherata, hanno percorso tutta la Salerno-Reggio Calabria diretti verso lo Stretto. Dopo posti di blocco, tamponi di verifica con esito negativo, con documenti in regola e certificato della protezione civile, sono riusciti a raggiungere la punta dello stivale, Villa San Giovanni. Qui l’inizio dell’inferno: a causa dell’opposizione agli sbarchi da parte del sindaco di Messina, i viaggiatori stremati sono rimasti sul molo per tre giorni e tre notti. Ed ecco l’apice della fama raggiunto grazie al programma di “informazione” gestito dalla D’Urso: in collegamento da Messina, noncurante delle leggi in materia di privacy, il primo cittadino sventola in diretta nazionale il dispaccio dell’autorità contenente nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza dei passeggeri, targa e revisione dell’auto: il video in poche ore ha ottenuto 3000 condivisioni. Ma, alla fine, gli esuli sono riusciti comunque a raggiungere la casa degli amici in Sicilia, da cui, via video, hanno chiarito la propria posizione: data l’assenza di un altro luogo dove poter adempiere alla quarantena, considerata l’emergenza, dopo l’autorizzazione delle forze dell’ordine, il gruppo si appella all’umanità e solidarietà comune, nella speranza che l’emergenza Coronavirus si possa arrestare il prima possibile. Ormai vicini all’applauso finale, la tecnologia diventa l’asso nella manica per il sindaco della città dello Stretto: ed ecco i droni che ovunque riproducono la soave voce del primo cittadino “Dove c***o vai? Torna a casa. Vi becco uno a uno. No passio, no babbio. Calci in c**o: ecco il modo per far applicare le norme. Non si esce, questo è l’ordine del sindaco De Luca e basta!”.
La posta in gioco è troppo alta per non aderire alla gara, così tanti altri primi cittadini, da nord a sud, hanno deciso di fare la propria parte: è il caso del sindaco di Tursi (MT) Salvatore Cosma che minaccia: “Io l’unica cosa che posso fare è che ve pozz rump ‘u ‘mus, così andrà a finire” e del sindaco di Boves (CN) Maurizio Paoletti che dichiara di voler aumentare il numero di loculi per ospitare coloro che trasgrediscono il divieto di uscire: “Se il piano A, Avviso, non funziona, passiamo al piano B, Bara”.
E mentre in maniera professionale, per le vie della Capitale, la sindaca Virginia Raggi spiega i rischi del virus Covid-19 agli abitanti che imperterriti continuano a fare jogging nei parchi, e il sindaco di Bari Antonio Decaro invita i concittadini presenti nel lungomare a rispettare il decreto, il primo cittadino della città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu utilizza la strategia del terrore.
Infatti, nella giornata di ieri, lungo le strade della città sono apparsi i manifesti m 6×3 firmati dal Comune: “Quando hanno portato mia madre in ospedale, ho capito che dovevo rinunciare alla corsa”, “Quando mio figlio è stato contagiato, ho capito che dovevo rinunciare a quella spesa inutile”, “Quando hanno intubato mio padre ho ripensato a quella passeggiata che dovevo evitare” recitano. In Sardegna sono 442 i contagi, 318 i casi nella provincia di Sassari e 74 in quella di Cagliari. Mentre la città del sole si svuota, lasciando spazio alla natura e ai suoi delfini, il sindaco intima il “memento mori” per una popolazione che, fatta eccezione per casi patologici che non riescono a rispettare le norme, cerca di fare la propria parte restando a casa.
E così, in piena emergenza Coronavirus, mentre il governo cerca di vestire quell’abito istituzionale da tempo dimenticato, guidato da colui che ora potrebbe facilmente essere definito “l’uomo d’Italia” Giuseppe Conte, a livello locale comincia ad affermarsi la figura del sindaco-sceriffo, in una competizione a chi ha la voce più grossa e a chi la spara più grossa. Sindaci, esito di una politica che dal 1994 ha cambiato le sue vesti.
Una politica che, anziché elevare lo status dell’interlocutore attraverso politiche di educazione, istruzione e welfare, per parlare a tutti, ha preferito cambiare la propria voce, abbassando il livello dei messaggi, delle parole, dei sentimenti, in un’inarrestabile degradazione sfociata in urla, insulti e scoop.
Una politica sempre più popolare, o meglio popolana, travestita da fratello maggiore che, facilmente, dimentica il proprio ruolo di vate. Una politica figlia di una classe istituzionale alimentata dalla demagogia e dal populismo, affermatasi grazie al tono di voce più alto e al capro espiatorio più succulento: sia questo incarnato dai cinesi o dai lombardi o da tutti coloro che si trovano oltre lo Stretto.
Una politica quotidianamente nutrita da un nemico esterno sempre ben nitido e facilmente distinguibile: sia esso il terrone, sia esso Roma ladrona, sia esso il profugo. Una politica che, inesorabilmente, ha perso il proprio ruolo di guida.
Politica condannata a perdere anche sé stessa, in favore del palco sempre acceso dell’eterno cabaret.